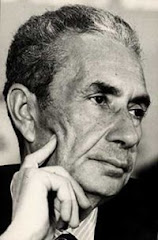14-11-10 - XXXIII Domenica del tempo ordinario – Anno C
Mal 3,19-20; 2Tess 3,7-12; Lc 21,5-19
Omelia
“dall’oriente e dall’occidente grande è il mio nome tra le genti…”
E’ forse Malachia un rappresentante di una tradizione che vede la possibilità di accogliere stranieri nel popolo di Dio se essi riconoscono il Dio d’Israele. Troviamo nella Bibbia diversi orientamenti al riguardo: c’è una spiritualità della chiusura, di chi pretendeva che ‘nessuno straniero, nessun incirconciso nella carne e nel cuore potesse essere ammesso al tempio. E’ questa la posizione di Esdra (cfr. Esd 7) e dell’ambiente sacerdotale del tempo del ritorno dall’esilio, del tempo della difesa di una identità dalle possibili contaminazioni con i popoli pagani. Malachia si pone piuttosto su di un’altra, quella dello sguardo del terzo Isaia: “Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo, e per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera… perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli” (Is 56,6-7). Il tempio non è concepito come segno di esclusione ma come luogo di accoglienza. Nell’ultimo capitolo del suo libro Malachia presenta il motivo dell’attesa di un ‘giorno del Signore’: al centro sta il messaggero che deve preparare la via. Secondo la tradizione ebraica Elia non era morto, ma trasferito in cielo (2Re 2,11), e sarebbe un giorno ritornato per accompagnare il popolo a prepararsi alla venuta di Dio. Elia è identificato con questo messaggero: ‘ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile’ (Mal 3,23). Il giorno grande è il ‘giorno del Signore’. Immagine che ritorna nei profeti. Amos lo indica vede come momento temporale in cui Dio fa irruzione in modo inevitabile e definitivo (Am 5,18-20): “Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso; entra in casa, appoggia la sua mano sul muro e un serpente la morde”. In una sequenza di minacce inevitabili il giorno del Signore è evocato come momento di un giudizio: nessuno può sfuggire e allora si compirà la speranza di giustizia e di pace presente nei cuori dei poveri. In quel giorno Dio stesso si scaglierà contro i buontemponi e contro gli ipocriti esecutori di un culto separato dalla vita: ‘piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente in piena’ (Am 5,24).
Malachia descrive questo ‘giorno del Signore’ con le immagini del fuoco e della paglia che si consuma. Dio stesso sarà ‘testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all’operaio, contro gli oppressori della vedova dell’orfano e contro chi fa torto al forestiero” (Mal 3,5). In contrasto con questa scena di fuoco, sta l’atmosfera di gioia di coloro che sono indicati come ‘cultori del nome di Dio’: per esso ‘sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla’ (Mal 3,20).
“Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta”
Anche nel vangelo di Luca, come in Marco e Matteo, a conclusione dell'attività di Gesù è presentato un discorso sulla città di Gerusalemme, sulla sua fine: Luca segue lo schema presente in Marco, una introduzione, lo sguardo al tempio e al suo ornamento di belle pietre e la parola di Gesù: "non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta" (vv.5-6). Segue l'annuncio della fine e della rovina di Gerusalemme e dei segni che verranno prima (vv.7-11.20-24). Infine l'annuncio della salvezza finale con i segni che la annunceranno (vv.25-33). Il discorso si conclude con un invito alla perseveranza nella persecuzione ed alla vigilanza (vv.12-19.34-36).
Gesù fa riferimento al ‘giorno del Signore’ a Gerusalemme, nell’area del tempio: (Lc 21,6). Attorno gli chiedono: ‘quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?” (Lc 21,7). Gesù si sottrae a domande inutili, che non cambiano la vita, soddisfacimento di curiosità senza ricadute in una prassi. Critica anche la ricerca di segni, in tutto funzionali ad una pretesa di dominio del futuro, attitudine superstiziosa e di idolatria. Invita invece a vivere la vigilanza, invita ad essere responsabili nel tempo presente, invita ad operare scelte che attuino la promessa del regno, in continuità con i suoi gesti. Tutti i motivi di prova e di persecuzione saranno occasione di rendere testimonianza e di scoprire la presenza forte dello Spirito che agisce nei cuori.
Il discorso di Gesù è davanti a tutto il popolo, non solo a pochi discepoli - come in Marco. Con accenti profetici, che riecheggiano le parole di Geremia di Michea, di Ezechiele, è evocata la fine di un tempo, l'avvicinarsi di un radicale cambiamento.
I segni che preannunciano tale svolta sono quelli che i profeti indicavano come i segni dell'intervento di Dio nella storia. Parlando di un giudizio di Dio da attendere annunciavano la caduta di Gerusalemme. Luca riprende questi motivi e riecheggia anche l'impressione dei suoi contemporanei per gli avvenimenti dell'intervento dei romani nel 70. In particolare egli vede nell'invito a fuggire dalla città il movimento di una chiesa spinta ad uscire verso le genti. Nel discorso di Gesù, Luca quindi presenta una riflessione sulla storia. In questa storia umana si rende presente la salvezza di Dio. La salvezza in Luca ha una dimensione di liberazione (dall'oppressione, da tutto ciò che opprime e sta alla radice di ogni esclusione e paura, un 'uscire al largo' - Lc 5,20-24 -) ed una dimensione storica: Gesù non segue la scelta della lotta armata degli zeloti, non la politica astuta di compromesso dei sadducei, e neppure l'atteggiamento dei farisei che nutre un'attesa facendo coincidere regno di Dio con le osservanze legali. La sua proposta di salvezza si connota come fedeltà estrema a Dio e solidarietà con gli uomini rovesciando le logiche di dominio e di oppressione, costituendo una comunità a partire dagli esclusi.
Di fronte alla distruzione del tempio compiuta dalle armate romane nell’anno 70 la comunità di Luca ricordava l’invito di Gesù: ‘quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non terrorizzatevi, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine”: non pensare quindi che è giunta la fine, ma vivere sin d’ora quegli atteggiamenti che sono in sintonia con il fine della storia, questo chiede Gesù ai suoi. Il regno di Dio si realizzerà alla fine ma già sin d’ora è all’opera e cresce in ogni scelta e in ogni atteggiamento di affidamento all’opera dello Spirito e di testimonianza di Gesù. Sta qui la fiducia del credente che fonda il suo impegno quotidiano sulle parole: “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”.
Dalla Parola alla preghiera
Cambia il nostro cuore Signore per aprirci alla fede e non seguire le varie curiosità di tipo religioso e la ricerca delle nostre sicurezze come idoli…
Donaci Signore il senso della fedeltà al lavoro e del guadagnarsi il pane. Donaci il senso delle cose ben fatte con le nostre mani e con la nostra intelligenza, facci comprendere il senso della fatica, donaci la gioia di vedere l’esito di un impegno che ha richiesto tempo e preparazione, donaci di saper educare i giovani a questo stile di vita…
Aprici ad un impegno di vigilanza e responsabilità nel presente: donaci coraggio e inventiva per rimanere svegli quando il torpore è diffuso, quando attorno prevale una religiosità di tipo magico e disincarnato…
Donaci di scoprire il senso dell’attesa profonda nella nostra vita, l’attesa del tuo venire che ci raggiunge nel nostro oggi e ci apre ad un futuro oltre ogni immaginazione…
Uno spunto da…
“Spero che i temi che via via espongo siano utili per sviluppare in direzioni finora poco considerate la discussione in corso sulla flessibilità del lavoro. Essa ricorda, mi permetto di dire, l’equipaggio di una barca che in mezzo all’oceano discuta animatamente delle modifiche da apportare al logo sulle vele anziché predisporre le misure per far fronte alla tempesta che si annuncia. Nell’oceano del lavoro la tempesta deriva dall’aver messo in competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e condizioni di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende con salari miserandi. La richiesta di accrescere i lavori flessibili è un aspetto di tale competizione. Il problema – smisurato – che la politica nazionale e internazionale dovrebbe affrontare sta nel far sì che l’incontro che prima o poi avverrà tra queste due parti della popolazione mondiale avvenga verso l’alto della scala dei salari e dei diritti piuttosto che verso il basso; che è l’esito verso cui finirebbe per condurci lo smantellamento delle protezioni legali dell’occupazione – uno dei tanti sinonimi della flessibilità. Proponendo che la politica si occupi di questo, piuttosto che del logo sulle vele, mi auguro di poter contribuire in qualche modo e misura a migliorare la condizione sociale e umana delle tante donne e uomini che ogni giorno sperimentano di persona che cosa significhi essere un lavoratore flessibile”
(L.Gallino, Il lavoro non è una merce, Laterza 2008)
Il titolo del libro di Luciano Gallino riprende un’espressione della “Dichiarazione di Filadelfia” del 1944 dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), ente collegato alle Nazioni Unite. Proprio questa organizzazione negli ultimi sessant’anni ha messo in risalto come nella tensione tra capitale e lavoro il processo di indebolimento e del venir meno della forza della componente dei lavoratori non producesse alcun risultato positivo nell’ambito della giustizia sociale ma anche, ad un altro livello nel potere d'acquisto dei lavoratori stessi.
Nel libro Gallino si confronta con le cause dell’attuale crisi economica e finanziaria trovandone le cause in processi lontani nel tempo a partire dagli anni 70 con la crisi petrolifera che segnò il momento di passaggio del sistema capitalistico occidentale verso scelte di rafforzamento del capitale a scapito delle conquiste avvenute a favore dei lavoratori nei trent’anni precedenti in cui era prevalso un indirizzo keynesiano e socialdemocratico.
Egli prende soprattutto in esame il lavoro flessibile e osserva come tale tipo di lavoro sia la conseguenza di precise scelte dal punto di vista politico ed economico. In fondo sta l’idea di pianificare il lavoro riducendolo a merce allargando la domanda di lavoro quando aumenta la richiesta di prodotti e facendola diminuire quando la richiesta di prodotti cala.
A questo si collegano altri fenomeni legati alla globalizzazione che per il lavoro significano fondamentalmente la delocalizzazione, ossia il trasferimento del lavoro nelle zone d’Europa e del mondo in cui non vi sono tradizioni sindacali, non c’è tutela giudica del lavoro e le norme per la sicurezza dei lavoratori sono di livello bassissimo.
Tale scelta della flessibilità del lavoro non produce alcun tipo di vantaggi né per i lavoratori di qui né per i lavoratori di altri luoghi, ma semmai produce solamente un guadagno per l’impresa, anche perché la delocalizzazione si accompagna con il venir meno delle forme di tutela sociale dei lavoratori. In buona sostanza Gallino sostiene che le promesse legate alla logica della flessibilità del lavoro di un miglioramento della qualità del lavoro e delle ricadute positive sulla vita dei lavoratori di fatto non si realizzano assolutamente. E le conseguenze stanno sotto i nostri occhi nelle diverse forme che sta assumendo la precarizzazione della vita delle persone con costi sociali difficilmente calcolabili. Un altro termine per lavoro flessibile è lavoro precario laddove la forma di contratto di lavoro dominante è quella del lavoro ‘atipico’ in cui la durata può essere di poche settimane. Ma quali i costi di tale precarietà che segna la vita soprattutto dei giovani? Le sue analisi al riguardo sono interessanti per la capacità di porre insieme attenzione non solo al dato economico, ma insieme ad esso il dato sociale e quello politico delle questioni che sono profondamente interrelati.
“Sono state le grandi imprese europee e americane, e italiane non poche, che hanno messo in rapporto grossomodo un miliardo e passa di persone da 5, 8, 10 dollari al giorno di retribuzione, quando tutto va bene (diritti zero, sindacati zero, eccetera) con il mezzo milione di persone di cui fanno parte i 25 milioni di lavoratori italiani che invece hanno retribuzioni che rispetto a quelle altre vanno sicuramente considerate ancora relativamente elevate, con diritti ancora notevolmente elevati e condizioni di lavoro umane, anche se in via di progressivo appesantimento. Cosa se ne trae da questo? Se ne trae che politiche del lavoro che volessero veramente evitare che il lavoro italiano, o europeo, o altro, scenda lungo le scale del diritto, delle retribuzioni, delle condizioni ambientali eccetera, verso le pessime condizioni che si osservano nei paesi emergenti, dovrebbe essere una politica, dovrebbe essere una serie di politiche che sono impegnate soprattutto a migliorare le condizioni di lavoro nei paesi emergenti” (L.Gallino in http://www.dossetti.com/corso/corso%202009/200907gallino.html)
Gallino propone due soluzioni di tipo politico alla situazione che egli vede profilarsi come aggravarsi di una condizione che già al presente vede nel mondo un 50 % dei lavoratori che non riesce a garantire a se e ai propri congiunti (2 o 3 a testa) più di due dollari al giorno, quindi con una media di guadagno di dieci dollari al giorno. Egli parla di ‘reddito base’ (basic income) e dello ‘stato come datore di lavoro di ultima istanza’. Il reddito base permetterebbe a chi si trova senza lavoro di non dover accettare qualsiasi condizione e qualsiasi tipo di contratto pur di lavorare, come invece accade. Due proposte da discutere ma che certamente possono aprire gli occhi sull’importanza del lavoro che non solamente è un diritto ma è anche un’esperienza della vita umana che non può andare senza diritti.
“Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi” (2Tess 3,7-12).
Dalla Parola alla vita
Qui di seguito la recensione di un testo uscito in Francia e che vede come autrici due donne, due che si definiscono una cattolica di tradizione l’altra cattolica da metà navata, ma che hanno vissuto un passaggio di responsabilità e di risveglio nel loro impegno di battezzate e di donne di fede che nutrono uno sguardo profondo per la vita della comunità ecclesiale nel suo insieme. (Anne Soupa e Christine Pedotti, Les Pieds dans le bénitier, Presses de la Renaissance)
Philippe Clanché La mia parrocchia è scoppiata, “Témoignage chrétien” 3417, 4 novembre 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
“Fino ad allora eravamo delle 'gattine addormentate', appena svegliate ci siamo accorte di avere le unghie”. In effetti, le due 'gattine', la giornalista Anne Soupa, 'cattolica della tradizione e cattolica del mio tempo', e l'editrice Christine Pedotti, 'cattolica da metà navata', non avevano nulla che potesse far pensare che sarebbero diventate delle agitatrici. Ma bastò una frase infelice - “l'importante non è avere una gonna, ma avere qualcosa nella testa”, pronunciata alla radio nel novembre 2008 da André Vingt-Trois – per far nascere questo duo protestatario. Il libro racconta dall'interno la loro avventura e la decisione di far nascere le loro due creazioni: il Comité de la jupe e poi la Conférence catholique des Baptisés de France (CCBF).
Unendo citazioni bibliche, riferimenti teologici e frasi a effetto, le due saggiste delineano il ritratto di una Chiesa cattolica in affanno. Della pietosa storia dell'atteggiamento della Chiesa verso le donne preferiscono ridere, dicendo, rivolte alla Vergine Maria, modello di femminilità difeso dalla Chiesa: “Perdonaci di averti ridotta ad una meringa bianca ed evanescente.” Rispondendo ad un argomento d'attualità, non si trattengono più: “In materia di contro-cultura, si vede soprattutto un piccolo club di vecchi signori in abito lungo che compuntamente vanno in processione o che dicono alla gente come comportarsi in camera da letto.” Sulla base di un approfondito studio sul battesimo, rivendicano per tutti i laici completa libertà di parola e di pensiero: “Non si tratta di obbedire al papa, al direttore spirituale o al Catechismo della Chiesa cattolica, ma di lasciarci cambiare, modellare dalla parola di Dio.”
Danno un nome alla malattia da combattere: la presbiterocrazia, il clericalismo, “non l'esistenza dei preti né la loro azione, ma la loro onnipotenza”, mentre “la Chiesa non è fatta esclusivamente da preti, né per i preti”. Fatta questa constatazione, severa, ma sempre argomentata, Anne Soupa e Christine Pedotti espongono il loro obiettivo - “far attenzione a mantenere un cattolicesimo insieme critico e aperto” - e la strategia della CCBF: “Né andarcene né stare zitti. Non chiedere niente e sperare tutto”. Finito il tempo delle rivendicazioni davanti alle porte chiuse di coloro che “negano la crisi e si ostinano a non cambiare nulla”. Lucide e critiche, ma “niente affatto disperate”, invitano i loro lettori a immaginare – a sognare – cento proposte da attuare. Per ridare stabilità alla casa che rischia di crollare, “la sola, autentica risposta è restituire al popolo di Dio, cioè a tutti i battezzati, il suo vero posto in tutta 'l'economia ecclesiale', ossia nella liturgia, nella predicazione, nell'annuncio del vangelo, nella presidenza delle comunità e nel governo parrocchiale, nazionale, romano”.
Di gradevole lettura, spesso gioioso, questo solido pamphlet di due innamorate della Chiesa è molto più di una semplice protesta. È da meditare seriamente”.
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)





.jpg)