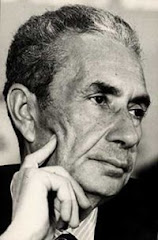XXVI Domenica tempo ordinario - Anno C - 2010
Am 6,1.4-7; 1Tim 6,11-16; Lc 16,19-31
“Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria!...
Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei buontemponi”
Ci sono due aspetti in questa invettiva di Amos contro i buontemponi del suo tempo, i ricchi che godono della loro straripante abbondanza senza guardare fuori dei propri sicuri recinti, disinteressandosi dell’altro.
Il primo è il rimprovero di ‘non pensare’: Amos rivolge secondo la formula tipica nell’ambito semitico un ‘guai’ verso gli ‘spensierati di Sion’. Questi spensierati sono accostati ai buontemponi ritratti in una sorta di entusiasmo orgiastico: godersi la vita, consumare, usare di ricchezze esorbitanti. E’ in fondo il ritratto di ogni società in cui qualcuno ha tutto e più di tutto e non si rende conto – in modo drammatico non vede - che vicino c’è qualcun altro che non ha nemmeno il necessario. Prima ancora dell’egoismo e della ingiustizia per Amos ciò che più preoccupa e genera l’indignazione del profeta è il non pensare. Pensare implica sempre porsi domande, lasciarsi inquietare dalla vita, dallo sguardo sulle cose e sugli altri, cioè al di fuori di sé, vuole apertura di mente e di cuore a scrutare oltre i confini rassicuranti, abissi e altezze. Chi evita la sfida e la fatica del pensare rinuncia ad una dimensione qualificante della persona umana e poco alla volta si rinchiude nella grettezza e nella superficialità di un cuore ristretto. E’ quanto si riscontra in esempi e figure di ogni tempo, dedite alla ricerca di un appagamento dei propri desideri per cui tutto, anche le persone, diventano solamente oggetti da utilizzare, da consumare e da gettare ed ogni mezzo è lecito al fine di perseguire i propri interessi personali. Per Amos è questo non pensare la causa profonda di una vita vissuta nel consumo e in un godimento che non si lascia interrogare dalla condizione dell’altro e soprattutto dalla miseria altrui. Il non pensare s’identifica con la rinuncia a ricercare il senso dei propri gesti e delle scelte che sempre generano relazioni che possono essere di segno diverso, di rispetto e di giustizia o per contro di iniquità e di oppressione. Non pensare non è solamente un’azione negativa, un non fare qualcosa, ma è scelta ben precisa, è rifiuto di guardare verso l’altro, di lasciarsi interrogare ed inquietare da quanto sta fuori del proprio piccolo raggio di vita; è la chiusura in un mondo fatto d’inseguimento di un illusorio piacere egoistico: “Canterellano al suono dell’arpa… bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati”
Ma c’è anche un secondo elemento a cui Amos è molto sensibile: si tratta del senso di sicurezza che avvolge la vita di questi spensierati e che è ricercato come condizione di base per poter escludere tutto ciò che può minacciare e disturbare una ricerca di godimento senza ombre. Va escluso, tenuto fuori, tutto ciò che potrebbe far scoprire la precarietà e la fragilità, la futilità di comportamenti, di consumi, di ideali. Va tenuto fuori anche tutto ciò che apre alla considerazione della condizione di altri: è la ricerca di una sicurezza che esclude e allontana dallo sguardo persone e situazioni avvertite come minaccia.
Potremo qui cogliere un motivo che interroga profondamente l’attuale contesto sociale dei Nord e dell’occidente del mondo: la condizione di ambienti sempre più segnati dalla paura della perdita di una sicurezza e che si rinchiudono nella ricerca egoistica di appagamento e di uso dei beni senza limiti e criteri.
“Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni”
Di Timoteo a cui è indirizzata questa lettera detta ‘pastorale’ si conosce qualche elemento della sua biografia: la nonna e la madre di cui sono fatti i nomi, gli hanno trasmesso la fede. Ci fu poi un rapporto affettuoso e profondo tra lui e Paolo. Si può pensare che pur essendoci stati altri compagni nella missione di Paolo, Timoteo abbia condiviso l'annuncio del vangelo come collaboratore stretto. A Timoteo Paolo affida il suo testamento (2Tim 4,6-8) e a lui ha trasmesso il 'deposito della fede' (1Tim 6,20; 2 Tim 1,14). Il 'deposito': non solo una serie di insegnamenti ma l'esperienza viva condivisa nella missione comune. A lui che ha ricevuto il dono della fede attraverso la testimonianza della rete di relazioni familiari è chiesto di combattere la buona battaglia della fede, e di conservare il comandamento. Secondo alcuni esegeti l'autore delle lettere pastorali potrebbe essere il medesimo Timoteo, che raccolse ricordi diretti della predicazione paolina, concentrandosi però su problemi propri delle comunità cristiane della seconda e terza generazione cristiana che vivevano momenti di prova e difficoltà. Dopo che Paolo non è più presente il riferimento alla sua figura e alla sua creatività teologica va fatto incontrare con situazioni nuove. Da qui il problema di fondo di questi scritti: come essere fedeli al 'deposito della fede'?
L’invito che sta al cuore di questa pagina è segnato da un aspetto di lotta, la buona battaglia della fede, ma implica anche una attenzione a conservare la testimonianza ricevuta: conservare implica necessariamente una continua interpretazione ed una fatica mai conclusa di tradurre il vangelo ricevuto in situazioni nuove e dai caratteri mutevoli. Tradizione è allora tutt'altro che ripetizione. Ai credenti non è affidato il compito di mantenere un dato statico e inanimato: la trasmissione della fede non è conservazione di una 'dottrina' ma condurre avanti una vita, far procedere una storia iniziata nei gesti e nelle parole del Signore Gesù, nell’attesa che dice riferimento ad un incontro con Lui nella gloria. Vivere la tradizione come esperienza comune della fede vivente implica l'esigenza di ritornare a Gesù e al suo vangelo e chiede di essere fedeli in modo sempre nuovo e creativo nei diversi tempi per incontrare Dio nel coinvolgimento dell'esistenza.
“C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta…”
In contrapposizione allo sfarzo e all’abbondanza della casa di Epulone, il riccone, la parabola presenta Lazzaro, povero, coperto di piaghe, che stava alla porta, ma fuori dalla casa dove si banchettava lautamente.
Il momento della morte giunge inesorabile, interrompe la spensieratezza di chi pensava solo a godersela e comporta un totale rovesciamento della situazione. La scena che si apre è diversa: Lazzaro è portato dagli angeli accanto ad Abramo mentre il ricco è immerso nei tormenti. Il punto focale della parabola non sta però in questa opposizione di destini, o nella presentazione della condizione degli uomini dopo la morte, anzi questa scena molto vivace nei suoi colori è tutta funzionale all’annuncio del regno che s’identifica con il ‘vangelo’ bella notizia per i poveri. Ed un secondo punto vertice starà nella domanda riguardante l’ascolto della Parola di Dio nel presente e le decisioni concrete di vita che ciò comporta. L’accento sta sulla responsabilità dell’oggi come luogo in cui si decide della propria vita in una prospettiva definitiva. E’ il medesimo messaggio presente in altre pagine di Luca dove si invita ad una vigilanza nel presente: “Guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione! Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame” (Lc 6,24-25).
Nel vangelo non troviamo una condanna semplicistica e manichea della ricchezza, come se di per sé i beni e il benessere siano un male: al contrario proprio la povertà e la miseria sono presentati come mali che Dio vuole eliminare. La condizione di Lazzaro è una condizione che non è esaltata ma è vista nella sua realtà di impoverimento e di degrado. Gesù nel suo agire annuncia che il regno è giunto, e il regno si connota come dono di una vita buona per tutti, possibilità di rapporti nuovi e di liberazione da tutto ciò che opprime e impoverisce l’uomo: la malattia come ogni altro male e la miseria sono da combattere e i gesti di Gesù attestano la sua cura per restituire le persone ad una vita serena. Gesù non condanna la condizione di avere dei beni. Denuncia invece la spensieratezza del ricco, l’indifferenza di chi gode senza volgere lo sguardo fuori della porta della sua casa, lì vicino dove c’è qualcun altro che soffre. I beni esigono di essere usati secondo uno stile di vita che tenga conto dell’indigenza e della sofferenza di chi non ha, e chi possiede dei beni è chiamato ad una condivisione. La presunzione e la superficialità del ricco sono considerati da Luca come un ostacolo insormontabile a comprendere la via che Gesù indica ai suoi.
La seconda parte della parabola presenta un dialogo tra il ricco e Abramo. Chiede ad Abramo di andare ad avvisare i suoi cinque fratelli, perché non abbiano a subire la medesima sorte. E la parabola si chiude con le parole di Abramo: “Hanno Mosè e i profeti: li ascoltino… Se non ascoltano Mosè e i profeti, anche se uno risuscitasse dai morti non si lascerebbero convincere”.
E’ qui il punto verso cui tutto il racconto converge: Mosè e i profeti sono le Scritture, indicano la storia della salvezza. La risposta di Abramo, padre dei credenti, richiama all’ascolto da attuare nella storia e nella vita. Non è questione di miracoli sorprendenti e di invii celesti: la volontà di comunione che sta al centro del disegno di Dio per tutti gli uomini può essere ascoltata e messa in pratica nel presente, sin d’ora. Esige scelte concrete che toccano il modo di gestire i beni. Non mancano possibilità, vicine e alla portata di tutti: ‘hanno Mosè e i profeti’. L’insensibilità generata dalle ricchezze può essere superata solamente con un’apertura all’ascolto che solo può cambiare la vita. E’ l’ascolto della Parola, il lasciarsi plasmare dall’incontro con Dio che si comunica a noi, secondo Luca, l’atteggiamento fondamentale che può far fiorire un modo diverso di rapportarsi agli altri.
Dalla parola alla preghiera
Rendici disponibili Signore ad ascoltare la voce dei profeti che ci raggiunge soprattutto nei testimoni di giustizia e di pace che talvolta in modo feriale e silenzioso, talaltra con forti appelli richiamano ad uno stile di vita fatto di attenzione ai poveri, di condivisione, di solidarietà.
Rendici capaci Signore di ‘vedere’ e di incrociare gli sguardi di chi è povero; apri i nostri occhi a scorgere la presenza dei poveri spesso allontanati e posti ai margini per non essere visti. Rendi il nostro orecchio sensibile al grido degli impoveriti, di chi è tenuto lontano dalla visibilità dei mondi dell’efficienza e del profitto
Cambia il nostro cuore Signore, donaci la disponibilità a lasciarci cambiare dal vangelo, bella notizia annunciata ai poveri nelle nostre scelte quotidiane di consumo, di stili di vita, di relazioni con gli altri.
Uno spunto da…
“Il progetto di Francesco era stato in effetti rivoluzionario, nel pieno rispetto del Vangelo: anziché prestare assistenza e carità senza abbandonare le certezze e i privilegi della propria posizione, come faceva la Chiesa, Francesco aveva voluto farsi povero tra i poveri, non possedere nulla, vestire una semplice tunica, vivere in cammino, predicare in maniera semplice e comprensibile. L’ala moderata dell’Ordine committente degli affreschi si era allontanata da questo progetto e non voleva vederselo rammentato con raffigurazioni di lebbrosi e accattoni nella magnifica Basilica, dove oltretutto giungevano personaggi importanti” (C.Frugoni, Le storie di san Francesco, Guida agli affreschi della Basilica superiore di Assisi, Einaudi 2010, 15-16).
Fra pochi giorni ricorderemo la figura di Francesco, un ricco che si fece povero, per arricchire molti con la sua povertà. Un uomo che progressivamente scoprì nella sua vita la forza irresistibile della chiamata di Gesù spogliato sulla croce, a seguirlo nudo nel riparare e rinnovare quella chiesa che Francesco comprese essere non tanto la chiesetta in muratura di san Damiano, bensì la comunità di coloro che seguono Gesù.
Nella basilica di san Francesco ad Assisi una serie di affreschi tradizionalmente attribuiti a Giotto, dipinti tra il 1288 e il 1292 al tempo di papa Niccolò IV primo papa francescano, rappresenta il percorso del giovane di Assisi, figlio del mercante Pietro di Bernardone. In particolare dalla prima alla quinta scena si delinea una sorta di percorso che vede Francesco essere raffigurato, dapprima sulla sinistra dei dipinti, poi, nella quinta scena, il suo spogliarsi delle vesti nella piazza di Assisi davanti al padre Pietro , sulla destra, ormai nudo e coperto solamente dal mantello che il vescovo Guido I gli regge attorno alla vita.
C’è una scelta di povertà fondamentale che segna la ‘conversione’ di Francesco, “che non volle mai farsi prete né volle mai accogliere alcuna delle regole monacali preesistenti… un uomo rimasto così sostanzialmente laico, che aveva apertola sua comunità ai laici, ai quali era stato permesso di rimanere tali” (ibid.); è una povertà incomprensibile agli occhi umani e che genera la reazione violenta del padre. Vestito di giallo al centro dell’affresco Pietro tiene in mano tutti i vestiti di Francesco tra cui si notano anche le brache. Giallo è il colore del mantello che Francesco vestiva, simbolo di una ricchezza che egli si trovò a condividere nella scena dell’incontro con il cavaliere impoverito. Il padre è trattenuto, forse da uno dei consoli riccamente vestito, nel gesto di indirizzare un pugno verso il figlio che rinuncia alle sue ricchezze e all’eredità. Alcuni bambini sulla sinistra in basso recano alcuni sassi nelle pieghe dei loro vestiti, pronti a lanciarli contro Francesco come si faceva con i folli e i dementi: la scelta di Francesco di rinuncia e di condividere la vita dei poveri appare così follia. Ma in tal modo Francesco manifesta la scoperta e l’incontro che lo guiderà nella vita: nel quadro egli alza le mani al cielo in segno di preghiera e dal cielo appare una mano che solca il cielo, la mano di Dio. Francesco ha scoperto la presenza del Padre di Gesù Cristo che significa per lui un modo nuovo di intendere il senso dei beni, della vita e delle relazioni con gli altri.
Le ventotto scene del ciclo di san Francesco ad Assisi sono elaborate sulla base della leggenda maggiore di Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell’Ordine nel 1258, che fu approvata nel Capitolo generale di Pisa del 1263 e unica biografia sopravvissuta dopo il 1266 quando un altro capitolo stabilì di distruggere tutte le biografie precedenti, per sanare le divisioni presenti nell’Ordine a proposito dell’interpretazione della Regola di Francesco.
Gli affreschi quindi riprendono il Francesco di Bonaventura rendendolo in tal modo un santo dolcissimo, in pace con tutti e con il creato e un santo inimitabile perché segnato dal miracolo delle stimmate mai prima avvenuto a nessun altro. E’ importante tener presente questa linea interpretativa di Bonaventura perché ad es. la scena dell’incontro con il cavaliere impoverito a cui Francesco dona il mantello è di fatto una rielaborazione di Bonaventura. Questi aveva infatti ripreso nel suo racconto l’incontro di Francesco con i lebbrosi riducendolo all’incontro con un solo lebbroso fuori della città e poi aveva parlato dell’incontro con un cavaliere nella città. Ma nel testamento di Francesco si legge: “Essendo io nel peccato, mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi; fu il Signore a condurmi fra loro e usai con essi misericordia. Quando venni via da loro, ciò che mi era parso amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e corpo. Dopo stetti un poco e poi uscii dal mondo”. Per Francesco è l’incontro con i lebbrosi un passaggio decisivo del suo incontro con Cristo: la sua è una scelta non solo di povertà, per seguire Cristo povero, ma anche di condivisione con gli emarginati. Il ‘vedere’ i loro volti lo ha cambiato e gli ha aperto la scoperta del Padre che chiede di condividere i beni e di condividere la vita. Povertà per Francesco è una via di incontro nuovo che ha radice nella scoperta del volto di Dio e si concretizza in una condivisione di vita, nella disponibilità ad incrociare gli sguardi dei poveri, un modo di riproporre il vangelo in modo radicale nel suo tempo.
Dalla Parola alla vita
Dieci anni fa, nel settembre del 2000, all’inizio del nuovo millennio, prima dell’11 settembre 2001, prima delle guerre in Irak e Afghanistan, 189 capi di Stato e di governo si erano riuniti ed avevano sottoscritto una dichiarazione che prevedeva l’impegno comune per sconfiggere la povertà nel secolo appena iniziato. Un impegno solenne, mai preso prima in modo così chiaro dagli Stati del mondo, articolato in otto obiettivi da realizzare concretamente entro entro il 2015: dimezzare la povertà estrema e la fame, garantire l’educazione primaria universale, promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l’Hiv/Aids, la malaria e altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. In questi giorni a New York si è tenuto il Summit speciale dei leader mondiali delle Nazioni Unite, con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento nella realizzazione di questi obiettivi. Obiettivi possibili, anche se ancora troppo poco si è fatto, se vi fosse un convergere degli Stati nel mantenere le promesse di contributi. Colpisce in particolare apprendere che l’Italia ha destinato lo 0,16 % del PIL per perseguire questi obiettivi (quando la stessa ONU indicava lo 0,7 % come obiettivo), ed ha offerto uno spettacolo scandaloso a livello internazionale nel non erogare i fondi che mai sono stati versati, ma furono promessi con grande concorso pubblicitario in occasione del G8 de L’Aquila.
E’ da ascoltare la valutazione di Vittorio Nozza, direttore della Caritas italiana, apparsa su Avvenire il 16 settembre u.s.: “Oggi, a cinque anni dal traguardo finale, a guardare il rapporto delle Nazioni Unite recentemente pubblicato sullo stato di raggiungimento degli obiettivi del millennio, si direbbe che negli ultimi dieci anni siano stati registrati risultati senza precedenti nella lotta alla povertà estrema, ma che vi siano anche ritardi inaccettabili nel raggiungimento di alcuni degli obiettivi intermedi. Dall’esperienza che viviamo accanto alle Chiese locali, constatiamo infatti che all’interno di molti Paesi, anche quelli più ricchi, le diseguaglianze continuano a crescere, generando aree sempre più ampie di miseri ed esclusi. Urge dunque una qualche 'correzione di rotta' sulle scelte, gli stili di vita, sull’uso delle risorse economiche ed ambientali, ma anche del nostro tempo e del nostro stare in relazione ogni giorno con tanti volti e storie di povertà che sollecitano prossimità. Circa un miliardo di persone nel mondo soffrono ancora la fame. Dietro questi numeri ci sono uomini e donne che vivono in condizioni disumane e che non possono aspettare che le promesse non mantenute dai governanti si traducano pienamente in fatti tangibili. Sono coloro che le Caritas incontrano tutti i giorni in molti paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, dell’Oceania, e anche dell’Europa, nei piccoli gesti, attraverso i progetti e gli interventi, nel tentativo di dare risposte concrete. Sono voci, volti e cuori che soffrono e chiedono giustizia e dignità.
Né la miseria, né l’ignoranza sono infatti un prodotto della 'natura' e tanto meno della 'fatalità'. Quelli che chiamiamo 'paesi poveri' sono quasi sempre paesi 'impoveriti, derubati'. Sono terre magari esposte anche alla rabbia dei venti, dei vulcani e degli oceani, ma il cui suolo rigurgita letteralmente di ricchezze. E se queste ricchezze venissero lasciate nel paese che le detiene e le produce, in Africa e in America Latina in primis? Purtroppo queste ricchezze vengono invece coordinate, sfruttate e drenate da multinazionali o aziende che stanno fuori, alla larga dal paese. All’interno di esso non vi è quasi alcuna ricaduta, sotto forma di proventi socialmente gestibili, per garantire dignità e sicurezza. Quel che colpisce di più, in questi paesi, non è dunque la miseria, ma la vertiginosa ingiustizia della distribuzione della ricchezza. E nell’ingiustizia non c’è un bel niente di inevitabile. C’è solo il regno di Mammona, già condannato senz’appello duemila anni or sono. Nella speranza non ci si deve arrendere. Continueremo a chiederci perché esistono ancora degli 'ultimi'. E non ci fermeremo, finché non sia fatta giustizia, con l’intelligenza e il cuore dell’amore”.
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)





.jpg)