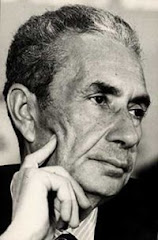18-4-2010 - III Domenica di Pasqua – Anno C
At 5,27-41; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
Omelia
“ma quella notte non presero nulla…”
C’è un fascino particolare nella pagina che chiude il quarto vangelo: è il fascino di quell’enigma che deriva dalla scrittura dei vangeli, dalla storia che precede la loro fissazione. Il cap. 21 è chiaramente un’aggiunta ad uno scritto già completato dove una conclusione indicava il senso di quanto era stato scritto: “perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome” (20,31). Nel cap. 20 già due narrazioni avevano presentato come Gesù si era mostrato vivente, dopo i giorni della sua ora, della passione e morte. Qualcuno, in un tempo posteriore, forse dopo la morte di Pietro, ha sentito la necessità di riscrivere, di rivedere e di aggiungere una pagina. Per rispondere alla domanda su cosa significa la risurrezione di Gesù per i suoi discepoli: se egli è il vivente questo comporta anche un percorso di risurrezione che coinvolge la comunità in relazione con lui. Le comunità che si rifacevano alla figura del ‘discepolo che Gesù amava’ sperimentavano la fatica, la durezza, l’aridità del loro cammino, vivevano il riferimento a due figure importanti ma anche la tensione tra Pietro e quel discepolo, la ricerca di una comunione possibile. Certo Pietro era il primo dei dodici, ma c’era stato chi era arrivato sempre prima e lo aveva preceduto nel cogliere il volto di Gesù, nello scorgerne la presenza con lo sguardo dell’amore e della profezia ora che dopo la morte non era più in mezzo ai suoi come prima. E bisognava credere imparando a leggere i segni, ma anche affidandosi a Lui senza aver bisogno dei segni. Domande non solo rivolte ad un passato che vedeva diversità di presenza e persone accanto a Gesù, ma anche per il presente di una comunità incerta e in cammino. Forse non solo ‘quella notte non presero nulla’, ma quel prendere nulla era un po’ il simbolo di un’esperienza, il senso di vuoto presente anche laddove si cercava - e si cerca oggi - di vivere il quotidiano senza troppe pretese e senza troppe attese.
C’è Pietro e ci sono altri sei discepoli con lui, sette, numero simbolico di una pienezza: tra di essi il discepolo che Gesù amava, coinvolti in un incontro che non prevedevano e che li trovava preceduti e impreparati. Ma è notte, è ancora l’ora del buio. Gesù si presenta loro quando già era l’alba, al momento del sorgere di una luce che non è solo la luce del sole ma è il presentarsi di una luce nuova che apre ad un vedere nuovo e diverso. ‘Gesù stette sulla riva’ ma non riescono a riconoscerlo. Ma è solo l’alba. Gesù chiede da mangiare rivolgendosi loro con parole affettuose: ‘figlioli amati’. Il suo farsi incontro è nei termini di una domanda e di un mendicare quasi, nell’amore. E mangiare insieme diviene evocazione e ricordo di tanti momenti di condivisione, del pane spezzato, dell’ultimo pasto condiviso nell’avvicinarsi dei giorni della Pasqua e nel buio che si stava addensando, il buio del rifiuto, dell’accusa, del complotto per uccidere Gesù. La ‘pagina aggiunta’ parla di un incontro, dell’iniziativa libera e gratuita di Gesù di ‘darsi ad incontrare’ dopo la sua morte: non è rimasto prigioniero della morte. C’è in gioco un evento che supera ogni progetto e pensiero umano: è evento di Dio. E’ vivente e si dà ad incontrare a quelli che saranno i primi testimoni: li accompagna in un cammino di affidamento e di conoscenza, li accompagna a ‘risorgere’. Gesù si fa incontro non con una imposizione della sua presenza tale da suscitare riconoscimenti eclatanti né con un rimprovero per il loro abbandono, né con l’indicazione di comportamenti da attuare d’ora in poi. Piuttosto le sue parole e i suoi gesti sono indicazione di dove si potrà incontrarlo d’ora in avanti e dello stile della comunità che dopo la Pasqua si forma sulla spinta interiore dello Spirito. Si presenta come mendicante: chiede, e la risposta è silenzio o non è detta, o è forse la sconsolata constatazione che quella notte non avevano preso nulla. E’ una domanda che rimane aperta, e un invito di buon augurio, l’esortazione a trovare: “gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete”.
L’esito a cui questa parola apre è sorprendente, va al di là delle attese, genera una abbondanza insperata. Solo allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “è il Signore”. I suoi occhi sono i primi che si sono lasciati toccare dalla luce di quell’alba. Anche lui ha avuto bisogno di segni; a differenza degli altri ha preceduto tutti nel saperli leggere. ‘E’ il Signore’ è il grido che racchiude il primo annuncio della fede: signore sulla morte, colui che torna, invocato in rapporto al futuro. Non chiuso nel passato della tristezza, ma vivo nel presente e che tornerà. Si apre uno squarcio di riconoscimento, sull’identità di Gesù, che ‘stette sulla riva’ mentre nessuno si era accorto che era lui. Ed è Simon Pietro a gettarsi per andargli incontro, nudo con la veste ai fianchi, quasi un battezzando che si immerge e si apre ad una vita nuova.
Nell’aridità di tempi senza frutto, nel silenzio di momenti in cui tutto è buio e tutto è notte attorno, la presenza di Gesù giunge a dire anche a noi che l’autentica fecondità di ogni impegno e di ogni sforzo non sta nella nostra capacità. Guida a ricordarsi di quelle parole: “Chi rimane in me e io in voi fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”.
La fecondità dell’annuncio del vangelo non sta nemmeno nell’avere mezzi potenti: quella chiesa, simboleggiata dalla barca che viene avanti appesantita della rete con tanti grossi pesci – rivelazione della debolezza di coloro che nemmeno riuscivano a tirarla su - è una chiesa che reca il frutto dell’accoglienza di una domanda e di una parola sommessa. Ezechiele aveva presentato una profezia in cui l’acqua che sgorgava dal lato destro del tempio era ricca di pesci (Ez 47,1.7-10) e le acque di En-Eglaim - le lettere di questa indicazione di luogo sommate secondo i calcoli ebraici danno il numero 153 - vedevano molte reti distese. Acque che giungono ovunque e reti aperte e distese senza confini. E’ forse il volto di una comunità che non osa nemmeno far domande e parlare: c’è già da mangiare eppure i discepoli si scoprono invitati a portare un po’ del pesce preso ora. E a vivere quei gesti dell’eucaristia: “prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce…”.
Una comunità che prima di offrire qualcosa è chiamata ad ascoltare le domande del Signore, ad accettare quello che Lui ha preparato, a portare il frutto di una fatica che è dono della sua parola, ad essere ancora accolta facendo proprio solamente il suo amore, il rapporto personale con il suo Signore. Solo così si può vivere la comunione alla sua risurrezione.
Uno spunto da…
Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, ed. Mondadori 2010.
«La notte è il luogo delle parole.
Le parole del diario di Beatrice hanno illuminato a giorno la mia prima notte da sveglio, la mia prima notte da vivo: la mia prima notte. Quella in cui gli altri fanno l’amore. Se il paradiso esiste sarà Beatrice a portarmici.
“Il dolore mi costringe a chiudere le palpebre, a nascondere gli occhi. Ho sempre pensato che avrei divorato il mondo con i miei occhi, come api si sarebbero posati su tutte le cose per distillarne la bellezza. Ma la malattia mi costringe a chiudere gli occhi: per il dolore, per la stanchezza. Solo poco dopo ho scoperto che a occhi chiusi vedevo di più, che sotto le palpebre chiuse tutta la bellezza del mondo era visibile, e quella bellezza sei tu, Dio. Se tu mi fai chiudere gli occhi è perché io stia più attenta, quando li riapro”.
Così c’è scritto sul diario di Beatrice. E io oggi chiudo gli occhi e guardo la vita con i suoi. Se la vita avesse gli occhi avrebbe quelli di Beatrice. Da oggi io voglio amare la vita come non ho mai fatto. Quasi mi vergogno di non aver cominciato prima.»
Alessandro D’Avenia , 32 anni, giovane scrittore, spiega il modo in cui è nato il suo libro: Bianca come il latte, rossa come il sangue (Mondadori 2010).
“Tre anni fa, al liceo Dante di Roma, coprivo un' ora buca ed è partito il gioco ‘massacriamo il supplente’. Mi sono giocato tutto parlando di storie, e dopo un po' un ragazzo racconta di una compagna di classe meravigliosa coi capelli rossi, che in un anno se n'era andata per la leucemia. Mentre parlava il suo volto caotico da adolescente si ricomponeva in un modo adulto. Dopo tre anni di elaborazione dell' episodio, Leo mi ha detto: scrivimi. Ho iniziato in terza persona, tre pagine e ho buttato tutto. Ho ricominciato con la sua voce e ne ho scritte 40 di getto”.
Nel romanzo che insegue i sentimenti e i percorsi della vita, Leo avverte in sé sé la forza racchiusa nel suo nome, quella di un leone, ma è anche impaurito: il nemico che lo atterrisce è il bianco. Il bianco è ‘un colore che non ha confini’, è l'assenza, sono le esperienze di dolore e privazione della vita. E’ quello che fa paura e che viene a galla ogni tanto come al momento della domanda del supplente, il Sognatore, prima che la campanella suoni: ‘Di cosa hai paura?’. Ed in contrasto al bianco il colore rosso che è il colore dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il colore dei capelli di Beatrice. Rosso è il colore del sangue. Quando controllano il suo gruppo sanguigno all’ospedale scopre di averlo del medesimo gruppo sanguigno di Beatrice. Spera che il suo sangue dopo il prelievo della donazione, le faccia bene. Rosso è anche il sangue di un Dio che spreca il suo sangue, quella “pioggia di amore rossosangue” che Leo scopre al momento del funerale di Beatrice, ascoltando quelle parole che per la prima volta gli toccano il cuore: ‘Questo è il mio sangue versato per voi’. Ed egli lo avverte come pioggia che “bagna il mondo ogni giorno nel tentativo di renderci vivi, ma noi restiamo più morti dei morti”.
Leo intuisce qualcosa nel rapporto con quel supplente il Sognatore con cui condivide il tempo della scuola: curiosando nel suo blog trova come egli condivideva la medesima passione per l’insegnamento del protagonista del film ‘L’attimo fuggente’ e “continuava con una frase misteriosa ma bella: ‘strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per questo sono al mondo’”.
Lo stare vicino a Beatrice diviene per Leo cammino di una scoperta, che fa ricordare e fa vivere: “Io credo che le uniche cose che che valga la pena di ricordare siano quelle raccontate con il sangue: il sangue non fa errori e nessun professore li può correggere. Il bianco di queste pagine non mi fa più paura e lo devo a Beatrice: lei, bianca come il latte, rossa come il sangue”. “Il mio corriso dice senza parole che quando cominci a vivere davvero, quando la vita nuota dentro il nostro amore rosso, ogni giorno è il primo, ogni giorno è l’inizio di un vita nuova”.
Dalla Parola alla vita
Nel giovedì santo di quest’anno a Milano il rito della lavanda dei piedi è stato svolto con dodici persone scelte tra lavoratori che hanno perso il lavoro, persone che sono state messe in cassa integrazione, giovani precari in cerca di occupazione che non si trova ‘perché il tessile è tutto fermo’, perché ‘le richieste e le commesse sono finite’, e la fatica si fa sentire soprattutto sulle spalle dei più deboli, dei meno garantiti. Sono i lavoratori licenziati coloro che più risentono della crisi economica che attanaglia il paese e che per magia scompare dalle notizie dei TG e dall’informazione pubblica.
Un gesto compiuto dal card.Tettamanzi che si è chinato a lavare e baciare i piedi di dodici lavoratori senza lavoro, segnati dalla crisi, per richiamare l’attenzione e per ricordare, proprio nel cuore della liturgia pasquale.
L’appello è se stiamo facendo abbastanza e se stiamo facendo proprio il possibile verso coloro che sono più provati in questo momento di difficoltà. Tra di essi in particolare gli stranieri che perdendo il lavoro si trovano immediatamente esposti alla condizione di irregolarità.
Gesù si dà ad incontrare nell’esperienza del lavoro dei suoi discepoli, mentre svolgevano il loro lavoro di pescatori. C’è una strana schizofrenia presente nella vita cristiana, quasi che Dio lo si possa incontarre solamente al di fuori dell’esperienza che occupa la gran parte del tempo delle proprie giornate, al di fuori del lavoro, al di là della fatica spesa nelle ore e nei giorni dedicati a quell’impegno che per alcuni può essere luogo della espressione e realizzazione delle proprie competenze ed energie per altri mezzo per sostenere la propria famiglia, occasione di sussistenza, base per poter vivere una vita dignitosa, anche se esso è faticoso, non gratificante e senza possibilità di creatività. L’incontro con Cristo risorto ha a che fare con i luoghi e il mondo del lavoro ed egli si fa vicino nel buio di chi si trova senza prospettive e senza lavoro. Si avvicina aprendoci gli occhi, rendendoci responsabili verso coloro che hanno perso la loro occupazione, verso chi sottosta ad un precariato senza limiti e senza sbocchi e solidali con chi vive questa sofferenza e queste umiliazioni.
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)





.jpg)