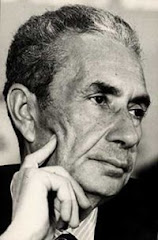1-8-10 - XVIII Domenica tempo ordinario - Anno C
Qoh 1,2;2,21-23; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Omelia
“Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male”
Qohelet è ‘il predicatore’, un sapiente, che ha lasciato uno tra i più inquietanti testi all’interno della Bibbia. Il suo non è nome proprio ma di funzione: viene da ‘qahal’ verbo del ‘fare assemblea’. E’ colui che parla nell’assemblea. Dedica il suo libro a Salomone: il re che ha costruito il tempio, è il re che ‘ha fatto’ una grande opera. Qohelet però fa ruotare il suo pensiero attorno ad una parola che non è solo un termine, ma è l’esperienza che egli ha della vita: ‘hevel’. Non è filosofo, ma sapiente che scardina ogni filosofia perché dentro a ‘hevel’ (con iniziale aleph) sta il riferimento ad Abele, la prima vittima. E per Qohelet tutto è ‘hevel’. Girolamo ha tradotto questa parola con ‘vanitas’. Erri De Luca (Kohelet/Ecclesiaste, traduzione a cura di Erri De Luca, ed. Feltrinelli 2007,5) traduce questo termine con ‘spreco’ ed in tale parola legge il confrontarsi di Qohelet con la prima vittima della violenza, il primo ucciso dal fratello della storia sacra. Il tutto è spreco, spreco di sprechi, come la vita di Abele, il suo sangue versato sulla terra: esso è spreco. Hevel/Abele è figlio di Adam. Così Qohelet legge l’intera vicenda di Adam sotto il sole. A differenza degli scritti sapienziali che nutrono un senso positivo della realtà e nel fare umano Qohelet presenta una lettura destabilizzante. “Ho conosciuto che non c’è un bene in loro, tranne essere allegri e fare un bene nella propria vita”. Non c’è un bene nelle opere di Adam, ma il bene è da fare nella propria esistenza e si deve attuare solo con allegria, sapendo che allegria è solamente dono di Elohim: “Ed anche l’ogni Adam che mangerà e berrà e vedrà un bene in ogni suo affanno: dono di Elohim esso è”. Diverso da Giobbe, Qohelet non è un sofferente, anzi, gusta ed è appagato dalle esperienze belle e gratificanti, brillanti della vita: ha goduto della ricchezza, della saggezza, dell’amore, del piacere e descrive la sua vita come sintesi di un percorso riuscito, senza drammi e senza dolori, nel successo (1,12-2,26). Eppure percepisce come tutto, sotto il sole, alla luce di Abele è ‘hebel/habel’, nebbia, vapore che si dissolve, schiuma lasciata da una barca tra le onde che presto scompare. Spreco.
“Perché c’è un Adam che il suo affanno è in saggezza e in conoscenza e in regola. E a un Adam che non si è affannato in essa gli darà la sua parte , anche questo è spreco e male molto. Perché cosa va a essere per l’Adam in tutto il suo affanno e nella compagnia del suo cuore: che lui si affanna sotto il sole?” Spreco – spiega Erri De Luca – “è il pensiero di stabilire dei meriti che dovrebbero corrispondere a dei risultati. Questo pensiero è spreco e porta a un gran male: l’opera pur fatta con affanno è premio a se stessa , non regge alcun termine di paragone con una qualunque opera altrui venuta meglio, costata meno” (p.31).
Qohelet è profondo ascoltatore dell’esperienza umana e ne denuncia le contraddizioni, la bugia sottesa, la finzione. Il suo pensiero è provocazione a un messaggio scandaloso che spinge a cogliere la presenza nascosta e paradossale della parola di Dio proprio laddove Dio è assente, nell’inconsistenza di tutto e nel lento sgretolarsi nel nulla della vita umana (cfr. il poema di Qo 12,1-7). Un messaggio che già un redattore finale del testo ha cercato di smussare nella conclusione (cfr. Qo 12,9-14) offrendo una esortazione che non rende ragione dell’inquietudine del libro: “conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l’uomo è tutto”. Nella traduzione di De Luca: “Fine di parola. Il tutto è stato ascoltato. L’Elohim temi e i suoi comandamenti custodisci, perché questo è tutto l’Adam”. E’ un testo arduo. Al suo cuore sta un verso di difficile resa: “Il tutto ha fatto bello nel suo punto; anche il mondo ha dato nel loro cuore, senza che troverà l’Adam l’opera che ha fatto l’Elohim, da testa e fino a fine” (Trad. De Luca). Quest’agire di Elohim che ha fatto bello tutto, nel suo punto, sta a significare allora che in ogni cosa c’è un punto, magari uno solo, di bellezza. Come dicevano i detti dei padri nel Talmud (Pirke Avot): “Non disprezzare alcun uomo e non svalutare alcuna cosa perché non c’è nessuno che non abbia la sua ora e non c’è cosa che non abbia il suo luogo”.
Da qui appare nel suo fascino la pagina centrale del libro: “Per il tutto una data; e un punto per ogni intento sotto i cieli. Punto per nascere e punto per morire…” (trad. De Luca). Punto non è indicazione generica per il tempo, ma è cogliere il momento, il “luogo d’impatto, tra fiocina e pesce, tra biglietto e vincita, asteroide e pianeta, punto in cui il divenire urta con l’improvvisa emergenza dell’inevitabile” (p.33).
“Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede”
Il ricco della parabola di Gesù è indicato come esempio di una stoltezza che non valuta il senso del tempo, non coglie precarietà della vicenda dell’uomo. Anche il Siracide si aveva presentato la vicenda del ricco preoccupato di immagazzinare beni. E non pensa, non sosta a riflettere sul tempo che gli è dato di vivere: “C’è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio; ed ecco la parte della sua ricompensa: mentre dice: ‘Ho trovato riposo; ora mi godrò i miei beni’ non sa quanto tempo ancora trascorrerà; lascerà tutto ad altri e morirà” (Sir 11,18-19). Il possidente teso ad ammassare è figura di un cuore duro incapace di comprendere, saturo di illusioni. “Voi dite: oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo affari e gudagni. E invece non sapete che cosa sarà domani! Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare” (Gc 4,13.14). Quel ricco è stolto. E stoltezza è l’atteggiamento di chi non tiene conto di Dio (Sal 14,1).
Gesù spinge a valutare il momento; riprende in qualche modo la provocazione di Qohelet. La vita non dipende dai beni. E’ piuttosto da cogliere il punto di bellezza presente in ogni persona e ogni cosa: per questo il tempo ci è dato. La grande illusione e idolatria è pensare che la vita dipenda dai beni, attaccare ad essi il proprio cuore, occuparlo di paure di essere defraudati e impoveriti. C’è un accumulo che rende schiavi, dipendenti delle cose; c’è un immagazzinare cose, proprietà, potere che non fa germogliare la vita, la rinserra. Per contro c’è un arricchire presso Dio, nella capacità di guardare con sguardo sereno le cose, di saperle usare, di vederle come buone, fatte per essere spartite, condivise, perché i beni siano alveo dove possa scorrere la vita propria e degli altri. Allora sì il tempo può essere vissuto, attraversato non appesantiti di pesi insopportabili, ma liberi di poter camminare.
Dalla Parola alla preghiera
Signore, rendici sensibili alla povertà e all’indigenza di chi è tenuto ai margini. Donaci coraggio per non essere dipendenti dalle cose, per non essere come chi ammassa senza preoccuparsi degli altri e senza arricchire davanti a te…
Signore, aiutaci a comprendere che la disparità economica mondiale e la diseguaglianza nell’uso delle risorse non è dovuta ad un destino cieco ma è frutto di scelte politiche e sociali ben precise, segnate dall’iniquità. Rendici attenti e responsabili ad orientare le scelte politiche nell linea della solidarietà e della giustizia.
Uno spunto da…
Giovanni Verga nelle sue Novelle rusticane (1883) presenta la figura di Mazzarò nella novella ‘La roba’ (Novelle rusticane
Einaudi Tascabili, 2005). Si potrebbe cogliere in lui la traduzione dell’uomo ricco della parabola. Qui si tratta di un uomo diventato ricco a partire da una situazione di povertà: si è fatto da solo, ha vvissuto il suo arricchimento come obiettivo assoluto della vita, ha sacrificato tutto per questo fine ed è rimasto profondamente solo, incapace di relazioni e di sguardo all’altro. Vittima del legame ad una roba fatta di proprietà agrarie e di produzione della terra. Egli intrattiene con la sua ‘roba’ un rapporto di legame e di dipendenza, fino a non voler staccarsene. Oppressore di altri poveri e a sua volta vittima della sua ansia di accaparramento. Si tratta di un esempio classico letterario, lontano forse da presente dove la ‘roba’ assume altri contorni – del denaro, dei possedimenti finanziari, del potere economico -, ma pur sempre occasioen per pensare di fronte ad un mondo non solo sommerso di ‘roba’, in cui la religione del mercato accomuna e uniforma e i nuovi templi appaiono essere i centri commerciali, ma in cui la rincorsa alla ‘roba’, la difesa delle proprie ricchezze e l’ampliamento dei magazzini appare essere al primo posto tra gli obiettivi della vita. Il gesto del vecchio Mazzarò che attraversa la sua aia barcollando ed agitando il suo bastone, e colpisce anatre e tacchini dicendo ‘Roba mia vientene con me’ è una triste metafora degli esiti dell’ideologia dell’accumulo e dell’interesse cieco di fronte agli altri.
“Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre; e altre file di muli, che non finivano più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che per mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a ripetere: - Curviamoci, ragazzi! - Egli era tutto l'anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre, ogni volta. Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, ché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il santo, colla banda, alle volte dovevano mutar strada, e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. (…)
Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! -
Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! –“.
Dalla Parola alla vita…
Da uno scritto di Alex Zanotelli, Il primato dei poveri (http://www.giovaniemissione.it/testimoni/primato.htm)
“…padre Ellacuría chiede ‘che si vada verso una civiltà della povertà, che si contrapponga a quella civiltà della ricchezza che sta portando il mondo alla propria consunzione senza per altro conseguire lo scopo di dare agli uomini la felicità che loro spetta’. Da Basilio a Ellacuría abbiamo una tradizione ininterrotta che mette al centro i poveri e domanda che lo ‘spezzare il pane’ sia il cuore dell'esperienza cristiana. E questo vale per i singoli cristiani come per le comunità e per l'istituzione chiesa. Ne troviamo una splendida esemplificazione in un testo di sant'Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della chiesa, quando parla dei beni della chiesa: "Colui che inviò senza oro gli apostoli (Mt 10,9) fondò anche la chiesa senza oro. La chiesa possiede oro non per tenerlo custodito, ma per distribuirlo e soccorrere i bisognosi. Dunque che bisogno c'è di conservare ciò che, se lo si custodisce, non è in alcun modo utile? Non è forse meglio che i sacerdoti fondano l'oro per il sostentamento dei poveri, piuttosto che di esso si impadroniscano sacrilegamente i nemici? Forse non ci dirà il Signore: Perché avete tollerato che tanti poveri morissero di fame, quando possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare loro? Meglio sarebbe stato conservare i tesori viventi che non i tesori di metallo".(…) Quando le niostre chiese italiane così cariche d’oro e di beni troveranno il coraggio di muovere i primi passi verso questa prassi? Davanti all'immane tragedia dei poveri, le nostre chiese resteranno ancora titubanti? "L'addobbo dei sacramenti è la redenzione, ossia il riacquisto dei prigionieri - scrive Ambrogio -. Vasi autenticamente preziosi sono quelli che servono a redimere gli uomini dalla morte. Tesoro vero è quello che realizza ciò che il Signore operò col proprio sangue".
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)





.jpg)