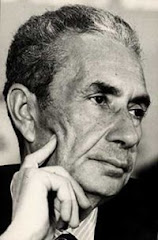2-5-10 - V Domenica di Pasqua - Anno C
At 14,21-27; Ap 21,1-5; Gv 13,31-33.34-35
Omelia
“Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede”
“Riunirono la chiesa”: quanto è diverso il modo di concepire la chiesa sotteso a questa breve pennellata di narrazione, rispetto ai modi diffusi a livello popolare e talvolta veicolati dal messaggio ecclesiale. Paolo e Barnaba ‘riunirono la chiesa’ ad Antiochia: è una piccola comunità composta di una molteplicità di volti e storie, eppure quella è la ‘chiesa di Dio’ presente ad Antiochia e lì la chiesa si manifesta non solo nelle presenza dei due inviati, ma in quel ‘noi’, in quella comunione, formata da tutti gli anonimi componenti di quella comunità locale nella sua povertà e nelle sue prove. Sarebbe bello riuscire oggi a compiere questo salto, a vedere e vivere la chiesa di Dio nelle comunità che si radunano a livello locale, sarebbe novità evangelica uscire dal clericalismo che ha ridotto la chiesa alle sue gerarchie, sarebbe scoperta di fecondità riconoscere il valore di riflesso dello Spirito di ogni servizio, il più piccolo e nascosto, che non porta a esaltare ‘ego’ di pochi, ma a edificare un ‘noi’, a lasciar spazio alla comunione che è la dimensione profonda costitutiva fontale della chiesa stessa. E’ ancora cammino da compiere ‘riunire la chiesa’ e percepire che nella povertà di una sparuta comunità che si riunisce e vive l’ascolto della parola, la condivisione, l’eucaristia, la diversità e molteplicità dei servizi, lì si visibilizza e fiorisce la chiesa di Dio chiamata ad essere serva del vangelo di Dio, che è disegno di comunione.
Alla chiesa Paolo e Barnaba portano non la testimonianza delle loro opere e dei loro successi. Piuttosto parlano di quello che Dio aveva fatto. Parlano soprattutto di porte aperte. E’ un agire - quello di Dio - che non impone pesi insopportabili, che non erige barriere, ma che apre porte, che fa varcare e oltrepassare soglie e confini.
Aprire le porte… potrebbe essere un bel programma di vita in un tempo di porte chiuse e inchiavardate, non solo nel rifiuto di lontani e diversi, ma sbarrate nelle comunità stesse di fronte alla spinta ad essere testimoni dell’apertura ad un agire di Dio che ha tolto la pietra dal sepolcro.
“Vi do’ un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”
La brevità di questa pagina è occasione per sostare e per cogliere il comandamento nuovo. ‘Nuovo’ non perché mai udito prima, ma perché è l’unica cosa che conta, perché è l’essenziale della vita. Rispetto a tanti altri comandamenti sui quali si è accentrata in modo talvolta ossessivo l’attenzione, sembra che Gesù ai suoi non chieda altro che una cosa: amatevi gli uni gli altri. Rimettere queste parole al centro cambierebbe tante esistenze di singoli, e lo stile della chiesa. Sono parole liberanti, che sganciano dalla logica di oppressione dei comandamenti e aprono ad una vita che si confronti con ciò che veramente è essenziale: il divenire se stessi nella relazionalità dell’amore all’altro. Tante sono oggi le sollecitazioni per intendere la vita come paura di perdere le proprie sicurezze, per rifiutare la sfida che l’altro con la sua presenza pone, per rinchiudersi e difendersi dagli altri perecpiti come minaccia, per tagliare i legami con il passato e con il futuro, barricandosi in un presente fatto di ossessioni e di sospetti. Il comandamento nuovo di Gesù per noi oggi è liberante: dice che la sfida dell’esistenza sta nel rapporto con gli altri. Coglie una dimensione al cuore di ogni desiderio umano, amare ed essere amati, in fondo riporta alla verità su di sé e sul proprio esistere. Ma amare è attitudine che esige precisazioni e chiarimenti contro tutte le forme di svuotamento di tale dimensione fondamentale.
Amare per Gesù rinvia al rapporto con lui stesso: “da questo vi riconosceranno come miei discepoli…” amando così si attua l’essere discepoli, cioè coloro che imparano e lo seguono, che stanno dietro a lui. C’è anche una precisazione sul modo particolare di amare: ‘come io vi ho amato’. Nell’uso di questo ‘come’ Gesù non indica una dinamica di imitazione, il prendere esempio da lui: non ne saremmo capaci. Non siamo in grado di amare in modo profondamente libero e disinteressato, giungendo a perdere, a dare la vita per gli altri. Questo ‘come io vi ho amati’ rinvia più profodamente ad una relazione, ad una partecipazioen di vita con Lui stesso, che diventa linfa che sola può alimentare i nostri percorsi di relazione e i nostri tentativi di amare. Quel tipo di amore non si apprende per altre vie se non nello stare in rapporto con lui, nel vivere un affidamento personale a lui rimanendogli aggrappati come i tralci alla vite. Lasciando che sia quella vita che non viene da noi a vivificare le nostre esistenze. Ciò a cui Giuda, appena uscito dal cenacolo, era rimasto chiuso, percependo che le richieste di Gesù mettevano in crisi radicale un certo tipo di religiosità fatta di tanti comandamenti ma priva dell’essenziale.
Spesso ci attardiamo in verifiche su tanti elementi che contano poco o talvolta nulla: se solo ci soffermassimo a pensare talvolta se abbiamo vissuto questo ‘comandamento nuovo’, forse l’unica cosa che ci verrà chiesta al termine della vita…
Uno spunto da
La porta (Simone Weil)
Aprite la porta, dunque, e vedremo i verzieri,
berremo la loro acqua fredda che la luna ha attraversato.
Il lungo cammino arde ostile agli stranieri.
Erriamo senza sapere e non troviamo alcun luogo.
Vogliamo vedere i fiori. Qui la sete ci sovrasta.
Sofferenti, in attesa, eccoci davanti alla porta.
Se necessario, l'abbatteremo con i nostri colpi.
Incalziamo e spingiamo, ma la barriera è troppo forte.
Bisogna attendere sfiniti e continuare a guardare invano.
Guardiamo la porta; è chiusa, intransitabile.
Vi fissiamo lo sguardo. Sotto il tormento piangiamo.
Noi la vediamo sempre gravati dal peso del tempo.
La porta è davanti a noi. A che serve desiderare?
Meglio sarebbe andare senza più speranza.
Non entreremo mai. Siamo stanchi di vederla.
La porta aprendosi liberò tanto silenzio.
che nessun fiore apparve né i verzieri.
Solo lo spazio immenso nel vuoto e nella luce.
Apparve d'improvviso da parte a parte, colmò il cuore
e lavò gli occhi quasi ciechi sotto la polvere.
(Simone Weil, Poèmes Suivis de Venise sauvée, Gallimard, Paris 1968 p. 35
tr. it. Venezia salva, tr. C. Campo, Adelphi, Milano 1987;
Poesie, Le Lettere, Firenze 1993)
In questa poesia di Simone Weil (1909-1943) la porta diviene immagine di una soglia che sta davanti, che viene guardata sotto il tormento e nell’esperienza del dolore. Rimane davanti come un limite ed una barriera da abbattere ma è troppo forte e invalicabile. E’ una porta chiusa. La porta esprime forse il limite di un oltre, di qualcosa che sta al di là del peso del tempo e della sofferenza. Ciò che è richiesto è l’attesa, il rimanere in un attenzione che si fa sfinimento nel continuare a guardare. Sta qui un elemento della sua riflessione sulla fede da intendersi non come sforzo, ma come attesa, come acconsentire che sia Dio a scendere verso di noi. In un suo scritto rivia all’esperienza della scuola, quando il professore chiede attenzione e la risposta è uno sforzo muscolare ma questo porta a concentrarsi su di sé, sul proprio sforzo, non su quanto ci raggiunge sul primato di un venire che chiede solo accoglienza. La porta è soglia di una luce che non giunge in virtù della forza di colpi. Solo ad un certo punto la porta si apre ed è l’irrompere improvviso, gratuito di una grazia che riempie il cuore inaspettatamente, quando il desiderio sta per esaurirsi. Lavacro di occhi quasi ciechi per il tanto guardare e attendere in una apparente passività – che è invece la più grande concentrazione e attività come disponibilità di accoglienza - che solo è luogo della grazia. Simone Weil ebbe a scrivere: “l’attenzione è la forma più pura della generosità”. “Una delle verità capitali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, è che la salvezza sta nello sguardo. … Lo sforzo grazie al quale l’anima si salva è simile a quello di colui che guarda, di colui che ascolta, a quello di una sposa che dice sì. E’ un atto di attenzione, di consenso … Con uno sforzo muscolare il contadino strappa le erbacce, ma soltanto il sole e l’acqua fanno spuntare il grano”. (Attesa di Dio, Milano 1998, 150)
Dalla Parola alla vita
Ritaglio dalla “Gazzetta del mezzogiorno” del 19 aprile 2010 alcuni brani della lettera a don Tonino Bello a cui si rivolge Nichi Vendola a 17 anni dalla morte. (A 17 anni dalla morte «Caro don Tonino, ho nostalgia di te» ), un ricordo accorato di don Tonino di fronte ad un mondo che contraddice tante sue parole ed il suo modo di guardare secondo il ‘comandamento nuovo’:
“Caro don Tonino, faccio sempre il gioco di provare a guardare il mondo mettendomi dal punto di
vista delle tue parole, inseguendo il tuo sguardo, inerpicandomi sulle vette delle tue domande rivolte
al gregge ma anche ai pastori, smarrendomi lungo le latitudini sconfinate del tuo pensiero di dio: del
dio che danza sulle gambe dei poveri, che si fa compagno piuttosto che giudice della storia umana,
che carezza i perdenti e annuncia la novella di una resurrezione dalla morte che stringe un nodo
potente tra il divino e l'umano, tra il tempo e l'eternità. (…)
Vedi, don Tonino, io sento nostalgia struggente della tua voce e della tua cosmogonia, perché ho
l'impressione che le cose si siano fatte molto più complicate. L'eroe del nostro tempo non è certo
quel tuo samaritano o zingaro o beduino che dinanzi a una qualunque vittima (e dunque dinanzi al
calvario di Cristo) «lo vide e ne ebbe compassione». Il sacerdote e il levita che hanno una certa
fretta autostradale, lungo la Gerusalemme-Gerico della nostra quotidianità, saranno loro i nostri
pedagoghi, la nostra fredda cattedra di realismo benpensante. Oggi vincono e convincono quelli che
non hanno tempo per occuparsi di vittime, di poveri, di esuberi, di quelle «pietre di scarto» che nel
Vangelo saranno le «pietre angolari» dell'edificio della salvezza: quelli che girano lo sguardo da
un'altra parte, quelli che fingono di non vedere l'orrore, quelli sono gli eroi di cartapesta del nostro
immaginario e della nostra etica pubblica.
Oggi gli afflitti vengono ulteriormente afflitti e i consolati ulteriormente consolati. Sembra un
universo capovolto con un dio seriale e mediatico, talvolta usato come un sedativo o magari un
eccitante spirituale, come un Internet teologico. (…)
Tu sapevi essere la sentinella che annuncia l'alba. E i tuoi scritti, le tue preghiere, le tue sacre
sfuriate, la tua dolcezza accogliente, erano fasci di luce che illuminavano i nostri passi.
Da un articolo di Maurizio Maggiani in “La Stampa Tuttolibri” del 24 aprile (Resistenza è ‘quer che se ciama dignità’) mi ha colpito l’importanza del raccontare e del comunicare la memoria, ma una memoria che rinvia alla vita e a quel’assoluto che cova nel cuore e che ha spinto uomini e donne a mettere in gioco la propria stessa vita per lasciare ad altri qualcosa che si chiama ‘dignità’, per aprire porte di dignità e di libertà: “Ogni volta che vado in una scuola, e mi capita spesso perché me ne sono fatto una passione, a parlare intorno alla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, continuo a raccontare ciò che mi è stato raccontato. Perché non si estingua quel sentimento di vita e di dignità, così semplice, così naturale, così necessario, che può essere raccolto da chiunque, generazione dopo generazione. (…) E per questa ragione, con gran sgomento dei professori, non propongo di leggere i romanzi di Calvino, di Cassola, di Fenoglio, che sono belli e importanti, ma assomigliano troppo alla letteratura, e dentro la letteratura cova sempre un di più, un di più che è ideologia e l’ideologia è il fossile della vita. Ma gli metto davanti le Lettere dei condannati a morte. E vedo che funziona, sempre. Vedo che nelle Lettere i ragazzi scoprono quanta vita e quanta verità ci fosse in quegli uomini che stavano morendo, quanta semplicità e quanto assoluto. Quel genere di assoluto che loro comprendono bene perché lo covano nel loro cuore”.
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)





.jpg)