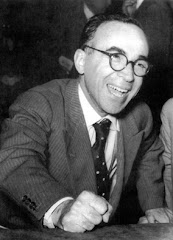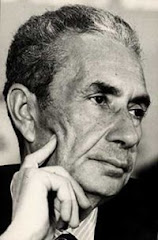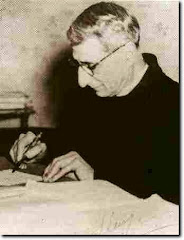Sap 3,1-9; Sal 41-42; Ap 21,1-7; Mt 5,1-12a
"Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace"
I libro della Sapienza da cui è tratta la prima lettura è nel suo insieme accostabile al genere letterario classico dei discorsi di encomio o di elogio che ha come tema di fondo l'indicazione di una vita nella sapienza di Dio. Starebbe in questo grande quadro la prospettiva di fondo che unifica le varie parti del libro, composto probabilmente per i giudei di Alessandria nel I secolo a.C. distinguibile in tre grandi sezioni: i primi cinque capitoli, una comparazione della vcenda dei giusti e degli empi, con l'indicazione che la sapienza di Dio avrà l'ultima parola, i capitoli da 6 a 9, con l'elogio della sapienza e la ricerca di Salomone che passa attraverso la preghiera, infine i capp. 10-19 nei quali è presentata la sapienza come chiave interpretativa dell'intera storia della salvezza e luce per leggere tutta la Bibbia, in particolare il cammino dell'Esodo. La sapienza di cui il libro tratta è la sapienza personificata, accostata allo Spirito di Dio, una sorta di effluvio e potenza divina, presente sin dalla creazione e la cui azione e presenza è efficace in coloro che la cercano. Il brano che oggi leggiamo è tratto dalla prima sezione in cui si afferma che l'uomo è stato creato da Dio non per la morte ma per la vita e nelle creature non c'è veleno di morte (Sap 1,14): "Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono" (Sap 2,23-24).
La visuale di fondo del libro della Sapienza è quella che proviene da Gen 1,26: l'uomo e la donna recano in sé l'immagine di Dio, partecipano di una vita che è fatta per entrare in una comunione senza fine con il Creatore. C'è una retribuzione ad una vita giusta ed una diversa per una vita empia al termine della vicenda umana.
In tale prospettiva la vita umana è luogo in cui rispondere a questa chiamata: si fa strada l'idea che la sorte dei giusti, benché sia messa alla prova dall'arroganza degli empi, nel mantenersi fedeli è una sorte carica di eternità: la morte mantiene la sua carica di dramaticità e rimane esperienza dolorosa, ma la speranza dei giusti "resta piena di immortalità". Pur se il libro utilizza una terminologia che risente dell'influsso della mentalità greca e con esso di un certo dualismo che divide la considerazione dell'anima e del corpo, l'antropologia propria del libro della Sapienza appare in continuità e sintonia con una visione unitaria dell'essere umano che nella sua interezza è chiamato a compiere l'immagine secndo cui è stato costituito, dono di relazione con Dio.
La pagina che oggi ascoltiamo ha anche un altro grande messaggio: c'è una 'vita da morti', si può percorrere il tempo come morti viventi o da moribondi. E' questa la situazione degli empi, una vita che apparentemente ha tutti i successi, ma in profondità è solo buio e distruzione degli altri e di se stessi. Per contro la vita dei giusti, di coloro che rispondono con fedeltà a Dio, benchè sia una vita apparentemente perdente, perché denigrata e sfidata con sottile ironia dagli empi che dicono 'mettiamo alla prova il giusto, condanniamolo ad una morte infame' (Sap 2,19-20), questa vita è nelle mani di Dio e vive nella certezza che Dio fedele non viene meno alle sue promesse. Oltre la morte c'è una promessa di vita e di speranza che già ora innerva le loro scelte.
"Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una nuova terra... E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate"
L'ultima pagina del Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse si chiude con una visione profetica sulla definitiva sconfitta del male: la storia vedrà un'ultima parola che sarà una parola di bene di vita e di luce: il 'mare', simbolo biblico delle forze oscure del male che si scatenano contro la vita umana, non c'è più. C'è invece una città - nella Bibbia tutto inziia in un giardino e tutto si conclude in una città - la nuova Gerusalemme, città della pace. La città è luogo collettivo e luogo del dimorare, di una presenza di Dio in mezzo al suo popolo, finalmente liberato: "egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro". La visione si allarga ad indicare alla fine un incontro di popoli. La morte non ci sarà più, e resta posto solamente per vita donata in abbondanza per tutti, gratuitamente come è data gratuitamente acqua per chi ha sete, dall fonte della vita. Ma è un punto di arrivo da guardare mentre si è ancora nella lotta e nella fatica della prova: "chi sarà vincitore erediterà questi beni: io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio".
"Beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno in eredità la terra"
Il testo delle beatitudini letto nel contesto della memoria dei defunti ci rinvia al senso della vita di Gesù come speranza di vita per tutti: è innanzitutto di lui che questa pagina ci parla, è lui innanzitutto che ha vissuto una vita nella linea delle beatitudini. Ed insieme a lui ci aiuta a riandare a tutti coloro che in questo spirito hanno inteso la loro vita, chi nella povertà, chi nel pianto, chi nella mitezza, chi nella lotta per la giustizia, chi nell'essere misericordioso, chi nel costruire la pace.
Il ricordo dei defunti è memoria gioiosa per il credente che legge le vite delle persone incontrate sul suo cammino, come segnate dal dono di una benedizione di Dio che raggiunge le persone oltre i nostri programmi e quanto nella loro vita è stato visibile: la preghiera eucaristica V ce lo ricorda nell'espressione "Ricordati dei nostri fratelli e sorelle defunti dei quali tu solo hai conosicuto la fede".
La memoria dei defunti vicina alla festa dei santi - da vivere in stretta continuità - ci fa accogliere la pagina delle beatitudini come promessa e appello di una storia segnata dalla vicinanza di Dio che prende le parti dei poveri, degli afflitti, dei miti, di chi tesse la pace e apre alla speranza la vita di chi si affida e scopre di non essere solo.
Alessandro Cortesi op
.jpg)


.jpg)

.jpg)



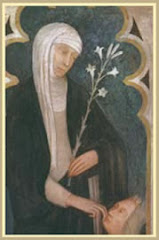

.jpg)